Cosa mangiano le cellule?
🧫 Le cellule del nostro corpo utilizzano una lunga lista di nutrienti e fattori di crescita e segnalazione per mantenere la loro vitalità. Vediamoli insieme!
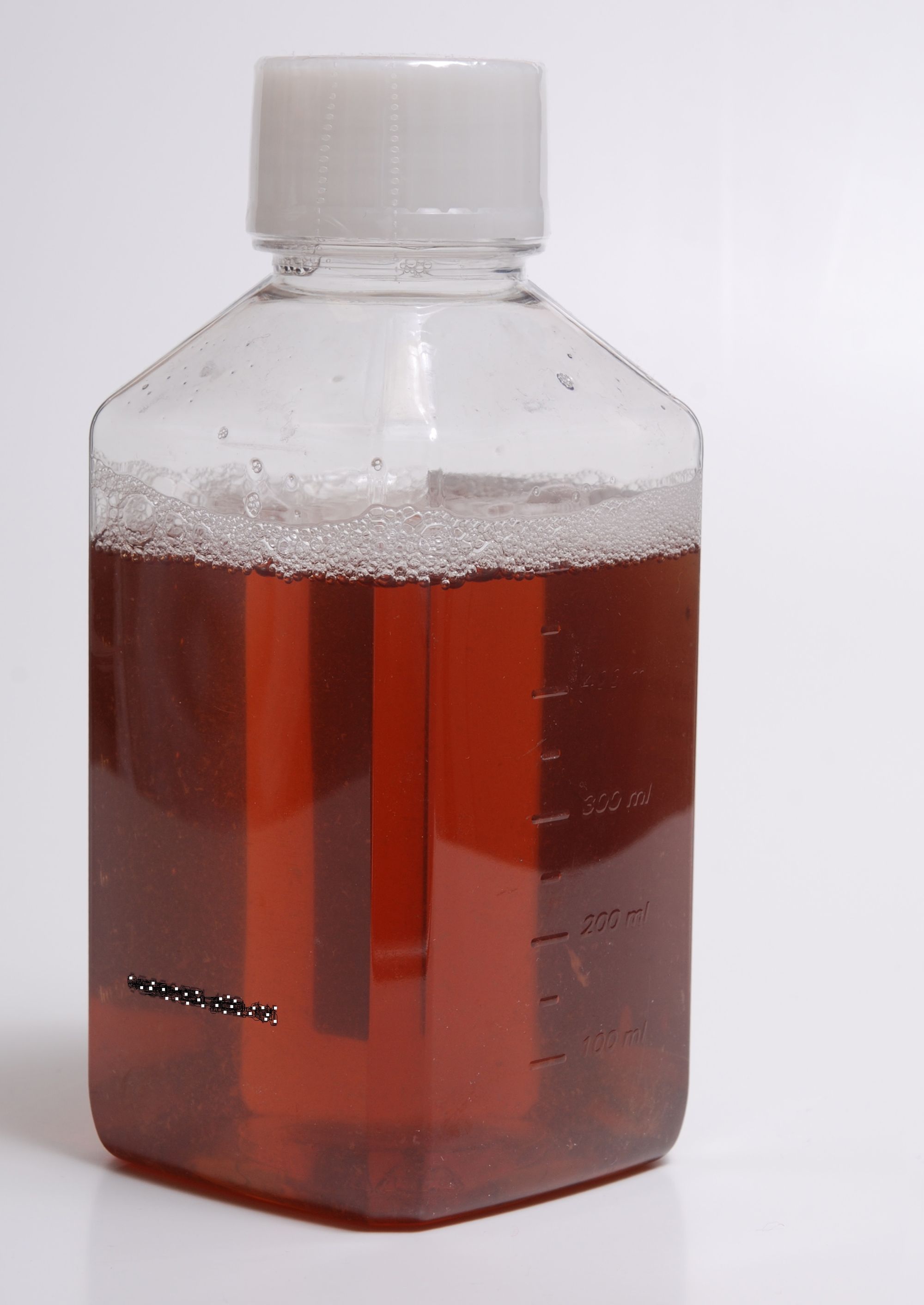
Le cellule del nostro corpo utilizzano una lunga lista di nutrienti e fattori di crescita e segnalazione per mantenere la loro vitalità, dividersi ed effettuare le loro attività fisiologiche e specifiche. Come le nostre, anche le cellule coltivate in vitro hanno bisogno di tutto questo affinchè possano essere utilizzate per i nostri scopi e soprattutto affinchè siano quanto più fedeli nel riprodurre le loro analoghe funzioni in vivo.
Quindi…cosa mangiano le cellule? scopriamolo insieme!
Partiamo dalla storia
All’inizio si utilizzavano fluidi corporei non definiti in composizione chimica come: siero, linfa, estratto di embrione di pulcino e simili. Ciò ha prodotto problemi di ripetitività delle condizioni sperimentali perché un siero può essere diverso dall’altro per vari fattori: stato fisiologico dell’animale, ambiente in cui cresce l’animale, tipo di alimentazione, la filiera di produzione.
Questo ha portato a comprendere che sarebbe più appropriato usare terreni di coltura definiti chimicamente.
Per identificare dei mezzi di coltura idonei per la proliferazione e il differenziamento di alcune cellule, c’è stata la complementazione di più approcci tra cui:
• analisi del microambiente in vivo dove vivono le cellule, come i fluidi corporei. Per esempio in riproduzione assistita, i terreni usati per lo sviluppo embrionale sono stati disegnati analizzando i fluidi nell’ovidutto (nelle tube di falloppio) ed è stata analizzata la composizione chimica del luogo dove si sviluppano le fasi dell’impianto embrionale ed è stato ricreato in vitro;
• utilizzo della biochimica nutrizionale analizzando il metabolismo del tipo cellulare, osservando i metaboliti preferiti e simili.
Terreni chimicamente definiti
In questo modo è stato possibile realizzare mezzi di coltura chimicamente definiti, quindi di cui conosciamo la composizione esatta e variando questa composizione possiamo renderli selettivi.
Fino a poco tempo fa la gran parte di questi mezzi di coltura definiti chimicamente venivano addizionati con una percentuale di siero e tutt’ora si fa con alcune colture cellulari. Ovviamente, però, se viene aggiunto del siero ad un mezzo definito chimicamente questo diviene non definito, per questo si cerca di minimizzare il tutto, cercando alternative sostitutive chimicamente definite.
Il siero da dei problemi simili a quelli che si possono riscontrare utilizzando dei fluidi biologici come terreni di coltura: cambia da animale ad animale, da momento a momento della vita di un individuo e quindi si hanno problemi di ripetitività.
La tendenza a generare terreni chimicamente definiti liberi da siero è forte riguardo la coltura di cellule specializzate o la produzione di biofarmaci (come l’interferone o l’albumina umana). Con terreni chimicamente definiti è possibile variare la composizione, le quantità e le qualità di vari supplementi in modo da incontrare i requisiti di crescita di un determinato tipo cellulare rispetto ad altri. Le tendenze attuali sono quindi delle alternative al siero e terreni selettivi per un solo tipo cellulare, in cui la proliferazione di altri tipi cellulari è sfavorita. Questo è un grande vantaggio nell’ambito delle colture cellulari.
Tra i vari tipi di mezzi di coltura troviamo:
- minimun essential medium (mem) disegnato da Egle. Successivamente c’è stata una modifica del mem fatta da Dulbecco e Freeman nel ’59, il Dmem;
- il mezzo di Ham nel ’65 che si chiama f12 e poi altri.
Ciò che hanno in comune sono i sali (per avere una certa osmolarità), glucosio e il rosso fenolo (indicatore del pH).
Questi mezzi, così come sono costituiti, sono chimicamente definiti anche se la loro composizione è segreto aziendale.
I componenti dei mezzi di coltura
Tra i vari componenti abbiamo una lunga lista di amminoacidi che variano a seconda del mezzo. Gli amminoacidi sono divisi in essenziali e non essenziali: gli essenziali sono quelli che le cellule non sono in grado di sintetizzare ex-novo e devono essere internalizzati da trasportatori specifici; I non essenziali sono quelli per i quali le cellule hanno vie di biosintesi specifiche ex-novo. Dunque, vengono chiamati essenziali quelli per i quali la cellula non ha vie biosintetiche alternative. Quelli non essenziali sono quelli per i quali la cellula, partendo da altre molecole, riesce a sintetizzare ex novo.
È presente anche una lunga lista di vitamine tra cui molto importante è il folato (Acido folico). Poi ci sono altre vitamine presenti in alcuni mezzi e non in altri o presenti a concentrazioni diverse.
Ci sono anche sali minerali: calcio, potassio, fosfato, magnesio, cloruro di sodio (principale) e possiamo avere anche il bicarbonato a concentrazioni diverse a secondo del mezzo. Elementi traccia, a piccolissime concentrazione, come il rame, ma non per questo sono poco importanti. Questi metalli (rame ,ferro, zinco e altri) sono importanti cofattori di molte proteine.
Ci sono, inoltre, alcuni componenti che riguardano il metabolismo energetico come coenzima-A, glucosio piruvato e sodio acetato e altri.
Troviamo i lipidi e loro precursori come colesterolo, acido linoleico.
I componenti con ruolo funzionale
Oltre al nutrimento, affinché un mezzo possa essere utilizzato per vario tempo e possa essere funzionale per l’operatore, ha bisogna di una serie di costituenti.
Il bicarbonato, anche se funge da sistema tampone, ha una bassa capacità tamponante, ma non è tossico, ha un basso costo e ha evidenti benefici nutrizionali.
Per quanto riguarda i tamponi organici non tossici usati c’è l’hepes con potere tamponante maggiore del bicarbonato e vicino al pH fisiologico (7.2-7.6). A volte sono usati assieme e la sua concentrazione è doppia rispetto a quella del bicarbonato.
Altra regola che riguarda i terreni di coltura è che, contrariamente al vivo, la gran parte del metabolismo delle cellule in coltura è glicolitica piuttosto che ossidativa e non vengono usati i trasportatori di ossigeno. Colture diverse hanno requisiti differenti: le colture di organo sono fatte in una capsula con mezzo di coltura e supporto metallico. Sono coltivati cioè all’interfaccia con l’atmosfera per massimizzare gli scambi di ossigeno. Si hanno però problemi perché si possono avere effetti tossici dovuti alla produzione di ROS (Specie reattive dell’ossigeno). In questo caso si posso usare scavengers dei radicali liberi come: il glutatione ridotto, agenti riducenti come il betamercaptoetanolo, il ditiotritolo, dei metalli in concentrazioni di traccia come il selenio che sono cofattori di molti enzimi come catalasi e superossido dismutasi che eliminano i ROS ed è anche cofattore nella sintesi di glutatione ridotto.
Il rosso fenolo, invece, è un indicatore del pH, quindi non ha ruolo nutritivo ma funzionale. Grazie a quest’indicatore, quando il pH del mezzo diviene troppo acido o basico, il colore vira in un senso o nell’altro permettendo all’operatore di avere informazioni sullo stato di salute delle cellule.
Il siero
Se usiamo una soluzione salina bilanciata o un terreno di coltura senza siero possiamo avere sopravvivenza delle cellule ma non proliferazione (a meno che non stiamo usando un terreno specifico, ideato per lavorare senza siero).
Affinché le cellule proliferino deve essere addizionato il siero, fonte naturale di nutrienti che contiene: lipidi, proteine, sali minerali, vitamine, fattori di crescita, una serie di componenti necessari per proliferazione e differenziamento. Il siero però è non chimicamente definito. Si pensa che contenga più di 1000 diversi componenti di cui molti non sono conosciuti.
Viene aliquotato, una volta nel laboratorio, e congelato a -20°C. Molto spesso viene scomplementato prima di usarlo. I fattori del complemento sono fattori che possono fissarsi a complessi antigene-anticorpo e fanno parte della nostra difesa immunitaria: quando abbiamo patogeni e anticorpi si formano i complessi antigene anticorpo e se ci sono i fattori del complemento si ha la lisi delle cellule cui si sono legati gli anticorpi. Questi vengono eliminati perché nel siero possono esserci anticorpi cross-reattivi con antigeni di superficie delle cellule coltivate e, se sono presenti i fattori del complemento, si genera citotossicità e le cellule vengono lisate. Per evitare ciò, siccome la gran parte dei fattori del complemento è termolabile, si può scongelare il siero a temperatura ambiente, metterlo per 30 minuti a 56°C (fattori di crescita e proteine del siero non sono molto impattati) per inattivarli evitando la citotossicità.
Il siero è variabile in composizione, ad esempio abbiamo:
• Proteine come albumina e fibronectina
• Veicolatori di ferro come la transferrina
• Inibitori di proteasi come l’alfa1antitripsina e l’alfa2macroglobulina
• Basse concentrazioni di fattori di crescita che vanno dall’epidermal-grow factor ad altri
• Aminoacidi a concentrazioni differenti
• Una serie di lipidi
• Carboidrati
• sali inorganici tra cui alcune tracce di selenio zinco
• Ormoni e vitamine.
Di alcuni di questi componenti si sa qual è la loro azione sulle cellule:
- I fattori di crescita e l’insulina sono nitrogenici, stimolano la proliferazione.
- Il fattore di crescita di derivazione piastrinica, il PDGF, stimola le mitosi.
- Altri fattori di crescita hanno invece effetto di induzione di differenziamento, come il fattore di crescita trasformante beta TGF beta che ha azione positiva sul differenziamento di cellule epiteliali.
- Fattori antiproteolitici e di adesione come la fibronectina che favoriscono la piastratura (ancoraggio) delle cellule. In generale la maggior parte delle cellule aderenti che coltiviamo sono di natura epiteliale, in questo tessuto la matrice su cui poggia l’epitelio è sintetizzata in parte dai fibroblasti del connettivo e in parte dalle cellule epiteliali stesse. Nella fase di latenza i fattori di adesione del siero aderiscono alla plastica e le cellule secernono altri fattori per cui la plastica si copre.
- Ci sono poi proteine del siero che veicolano e regolano questi complementi (minerali lipidi e ormoni) e li rendono disponibili.
- Fetuina e transferrina legano ferro rendendolo non tossico e biodisponibile.
- L’insulina stimola l’assunzione di glucosio e amminoacidi inducendo la proliferazione.
- L’ormone della crescita: a seconda del tipo di siero che usiamo, da vitello (fetal calf sierum) o da embrioni bovini. In tal caso abbiamo contrazioni di ormoni della crescita elevati.
- L’idrocortisone può favorire adesione e proliferazioni, ma su particolari linee cellulari agisce da citostatico e tali conoscenze hanno portato allo sviluppo di terreni liberi da siero per queste linee cellulari particolari.
Possiamo testare un nuovo siero prima di usarlo, perché può avere effetti indesiderati. Può avere azione di inibizione della proliferazione (lo possiamo vedere allestendo le curve di crescita), e ciò può essere dovuto a:
- Contaminazione batterica durante la produzione industriale, per cui sono liberate delle tossine nel siero e, dopo le fasi di sterilizzazione, non sono più presenti i batteri ma il siero è diventato tossico.
- Presenza di anticorpi cross-reattivi con le cellule. Alcuni anticorpi sono citotossici senza bisogno dei fattori del complemento.
- Diversi lotti di produzione del siero possono essere diversi per lo stato di salute generale dell’animale e quindi poi per il processo di produzione.
Sterilità
Nonostante le attenzioni a non contaminare le cellule in coltura con microorganismi, è possibile avere delle contaminazioni a causa di operazioni sbagliate (es toccare inavvertitamente superfici non sterili con le pipette; lavorare con una cappa troppo affollata di materiale e che non assicura più un ambiente sterile ecc.). Quindi, è spesso necessario addizionare antibiotici ed antimicotici ai mezzi di coltura. Questo è tanto più vero se lavoriamo su colture primarie o utilizziamo tecniche che comportano un elevato dispendio di tempo e soldi o lavoriamo con cellule preziose. Ovviamente antibiotici diversi hanno diversi spettri di azione, diversi effetti anti-metabolici anche sulle cellule in coltura e diversi tempi di degradazione spontanea.
Molti laboratori li evitano perché possono favorire, come negli ospedali, la formazione di resistenza agli antibiotici cioè di sviluppo di ceppi batterici resistenti.
Però per alcuni tipi di colture, come le primarie o di cellule preziose magari provenienti da biopsie o di liquido amniotico o diagnosi prenatale per biopsia dei villi coriali o fecondazione in vitro, molto spesso sono usati.
L’articolo è finito, adesso potrai dire di sapere cosa mangiano le cellule ma anche…come vengono mantenute in vita!!
Angela Nacca
Ti è piaciuto l'articolo?
 BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.
BioDaily.it non riceve alcun contributo pubblico né ospita alcuna pubblicità, quindi si sostiene esclusivamente grazie alle donazioni dei lettori. Ti ringraziamo qualora tu volessi fare una donazione al nostro progetto, puoi farlo cliccando su questo messaggio.
